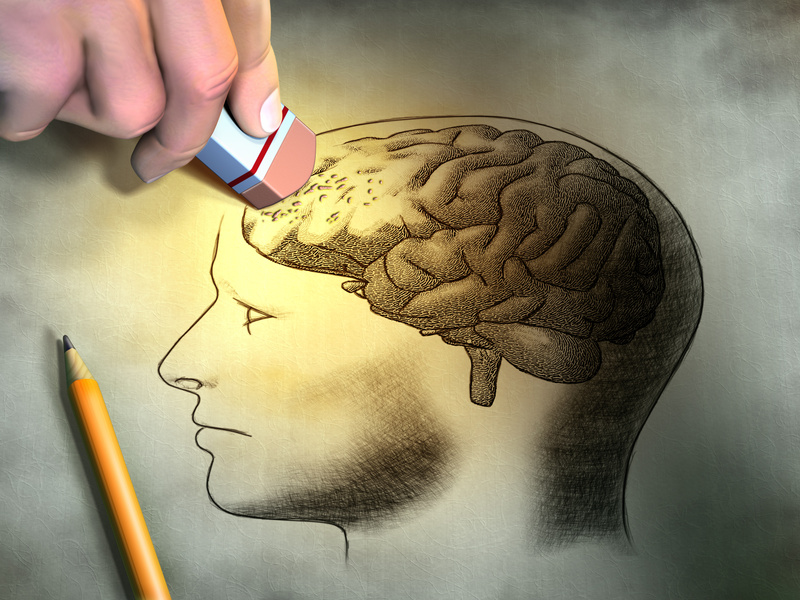Due tra i più importanti pensatori italiani discutono di etica, gnoseologia, politica e religione in dieci lettere raccolte nel volume Controversia sull’essere (Rosenberg & Sellier)
La filosofia del Novecento è stata contrassegnata dal conflitto tra due principali correnti di pensiero: gli «analitici» e i «continentali». La filosofia analitica – sviluppatasi soprattutto nei Paesi anglosassoni – si è impegnata nello studio dei termini linguistici per distinguere i discorsi prettamente scientifici da quelli metafisici. La filosofia continentale – diffusasi soprattutto dentro il continente europeo – si è occupata invece di tematiche non rigorosamente scientifiche (estetica, etica, metafisica, ontologia, politica, ecc.) che indagano il senso dell’esistenza umana (vedi Franca D’Agostino, Analitici e continentali, Raffaello Cortina; Alessandro Rosa, Analitici e continentali: il mestiere del filosofo, in www.thewisemagazine.it).
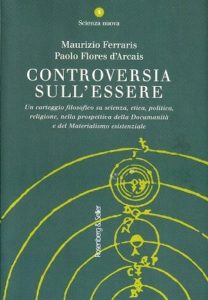 Della filosofia continentale hanno fatto parte molteplici indirizzi di pensiero (ermeneutica, esistenzialismo, fenomenologia, marxismo, psicanalisi, ecc.), ma in particolare il postmodernismo, che ha egemonizzato il panorama filosofico internazionale tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI. Le sue origini risalgono al 1979, quando il pensatore francese Jean-François Lyotard ha scritto che «possiamo considerare “postmoderna” l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni» (La condizione postmoderna, Feltrinelli), decretando così la fine delle grandi ideologie (cristianesimo, idealismo, illuminismo, liberalismo, marxismo, ecc.). Il pensiero postmoderno ha fatto proprio il prospettivismo di Friedrich Nietzsche – secondo il quale «i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni» (Frammenti postumi 1885-87, Adelphi) – e ha messo in discussione il progresso tecnico-scientifico, promuovendo l’ambientalismo e la «cultura della differenza» (contro ogni discriminazione razziale, sessuale e sociale). I detrattori del postmodernismo, tuttavia, hanno tacciato i suoi esponenti di neoconservatorismo e, in particolare, il filosofo statunitense Frederic Jameson li ha etichettati come ideologi del capitalismo globalizzato (vedi L’originale filosofia di Fredric Jameson tra neomarxismo e postmodernismo, in http://www.bottegaeditoriale.it/direfarescrivere.asp).
Della filosofia continentale hanno fatto parte molteplici indirizzi di pensiero (ermeneutica, esistenzialismo, fenomenologia, marxismo, psicanalisi, ecc.), ma in particolare il postmodernismo, che ha egemonizzato il panorama filosofico internazionale tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI. Le sue origini risalgono al 1979, quando il pensatore francese Jean-François Lyotard ha scritto che «possiamo considerare “postmoderna” l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni» (La condizione postmoderna, Feltrinelli), decretando così la fine delle grandi ideologie (cristianesimo, idealismo, illuminismo, liberalismo, marxismo, ecc.). Il pensiero postmoderno ha fatto proprio il prospettivismo di Friedrich Nietzsche – secondo il quale «i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni» (Frammenti postumi 1885-87, Adelphi) – e ha messo in discussione il progresso tecnico-scientifico, promuovendo l’ambientalismo e la «cultura della differenza» (contro ogni discriminazione razziale, sessuale e sociale). I detrattori del postmodernismo, tuttavia, hanno tacciato i suoi esponenti di neoconservatorismo e, in particolare, il filosofo statunitense Frederic Jameson li ha etichettati come ideologi del capitalismo globalizzato (vedi L’originale filosofia di Fredric Jameson tra neomarxismo e postmodernismo, in http://www.bottegaeditoriale.it/direfarescrivere.asp).
La disputa tra scienza e filosofia è stata riproposta in Italia da Maurizio Ferraris e da Paolo Flores D’Arcais, che hanno recentemente pubblicato il saggio Controversia sull’essere. Un carteggio filosofico su scienza, etica, politica, religione, nella prospettiva della Documanità e del Materialismo esistenziale (Rosenberg & Sellier, pp. 260, € 16,00). Il volume è composto da dieci lettere, scritte tra il 2012 e il 2020, nelle quali i due filosofi si confrontano – come si legge nell’Introduzione – in «uno scontro argomentativo, un polemos (guerra!) di argomentazioni a sostegno di tesi opposte o comunque assai diverse».
Ferraris è stato a suo tempo uno dei primi esponenti del postmodernismo italiano, insieme a Massimo Cacciari, Aldo Rovatti e Gianni Vattimo, ed è noto per la pubblicazione del Manifesto del Nuovo Realismo (Laterza, 2011). A partire dal 1997, tuttavia, ne ha preso le distanze, criticandone «l’iperbole antirealista» che ha prodotto – a suo parere – gravi aberrazioni e ha reso plausibile qualsiasi punto di vista (ad esempio, il “terrapiattismo”). Egli, pertanto, ha elaborato il «nuovo realismo», una prospettiva filosofica che considera la realtà naturale come «inemendabile» (ossia indipendente dal soggetto che la osserva), discernendo nettamente i fatti dalle interpretazioni. Ferraris ha poi costruito – nel saggio Documanità (Laterza, 2021) – un’«ontologia sociale», cioè un compiuto sistema filosofico su basi naturalistiche e sensistiche, rigettando sia il relativismo gnoseologico ed etico dei pensatori postmoderni, sia la visione neopositivista che valuta la scienza come l’unica fonte attendibile del sapere.
Il filosofo neorealista è convinto, inoltre, che il mondo stia attraversando una fase di transizione verso una nuova era storica, caratterizzata da un diverso sistema economico-sociale. L’automazione completa della produzione e lo sviluppo incessante del web – a suo avviso – porteranno in un futuro non molto lontano alla nascita della “documanità”, un nuovo tipo di umanità che sarà libera dal lavoro manuale e avrà solo il compito di consumare merci e registrare documenti nei Big Data, determinando così «un rivolgimento del modo di pensare che ci ha accompagnati nel tempo».
Flores D’Arcais – celebre direttore della rivista MicroMega – ha criticato vari aspetti del «nuovo realismo», proponendo in alternativa il «materialismo esistenziale», un’originale concezione filosofica che distingue «tra scienza come dominio dei fatti e filosofia come dominio dei valori». La conoscenza scientifica – a suo avviso – non può essere ridotta alla stregua di una delle tante forme culturali dell’«ontologia sociale», perché si fonda sul metodo sperimentale e possiede una valenza gnoseologica superiore all’arte, alla filosofia e alla religione. Flores D’Arcais, inoltre, è convinto che compito della filosofia non sia la conoscenza obiettiva del mondo naturale, bensì la riflessione negli ambiti dell’etica e della politica, dove regna il pluralismo dei valori e occorre scegliere le soluzioni pratiche più adatte alla sopravvivenza della specie umana. Egli, pertanto, sostiene con tenacia il «primato dell’azione etico-politico rispetto all’attività filosofica in senso stretto» e si rifà sul piano morale all’esistenzialismo di Albert Camus, che ha saputo coniugare il pessimismo antropologico con l’ateismo radicale e i valori democratici (vedi Diego Fusaro, Albert Camus, in www.filosofico.net).
Senza entrare nel dettaglio delle dotte argomentazioni portate dai due autori a sostegno delle rispettive tesi, ci limitiamo – in conclusione – ad esprimere un nostro breve giudizio sulla loro controversia filosofica. Il «materialismo esistenziale» di Flores D’Arcais ci appare più convincente del «nuovo realismo» di Ferraris, al quale comunque va riconosciuto il merito di aver rinnovato il pensiero filosofico italiano. Condividiamo, infatti, molte delle critiche che il direttore di MicroMega ha rivolto all’amico filosofo, citando in particolare un brano contenuto nella parte iniziale della sua terza lettera: «a mio parere la guerra che muovi agli idealismi e alle ermeneutiche postmoderne resta prigioniera del loro orizzonte, e dunque il tuo New realism resta impigliato nella loro egemonia».
Giuseppe Licandro
(LucidaMente 3000, anno XVII, n. 193, gennaio 2022)