Abbiamo intervistato la scrittrice e fotografa, reduce da un (altro) lungo viaggio. Intrapreso come sempre in solitaria, le ha anche fornito lo spunto per il suo nuovo libro “In Alaska. Il paese degli uomini liberi” (Ponte Sisto editore)
Siamo abituati a leggere le sue riflessioni sulle differenze tra il mondo occidentale, tecnologico e “moderno”, e quello indigeno, più naturale e armonioso, sebbene bistrattato e “spremuto” dai poteri forti; siamo anche soliti viaggiare con lei attraverso pagine intrise di esperienze e dei colori dei luoghi più lontani. Stiamo parlando della scrittrice, fotografa e viaggiatrice solitaria marchigiana che non teme distanze né climi estremi né tantomeno condizioni di vita spartana: Raffaella Milandri.
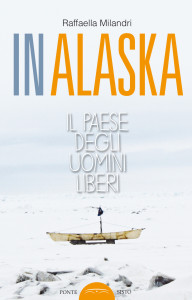 Già ospite sulla nostra rivista per descrivere percorsi avventurosi, dare testimonianze (Caccia alle “streghe” in Papua Nuova Guinea) e lanciare appelli su cause umanitarie solitamente ignorate dai mass media occidentali (Il Nepal dopo il terremoto), l’eclettica Milandri non si ferma mai. Tra un viaggio in capo al mondo e i tanti impegni in Italia con l’associazione Omnibus Omnes, da lei fondata a tutela delle popolazioni più deboli, l’autrice ha raccolto l’ultimo itinerario, svolto in condizioni estreme, nel suo quarto libro, In Alaska. Il paese degli uomini liberi (Ponte Sisto editore, pp. 152, € 14,00). L’abbiamo intervistata per farci raccontare in prima persona la sua capacità di entrare in punta di piedi nelle culture differenti, di approcciarle e di saper ascoltare le voci meno fortunate, ma anche per scoprire stati d’animo non scontati, obiettivi e qualche segreto legato a partenze e ritorni di una donna instancabile.
Già ospite sulla nostra rivista per descrivere percorsi avventurosi, dare testimonianze (Caccia alle “streghe” in Papua Nuova Guinea) e lanciare appelli su cause umanitarie solitamente ignorate dai mass media occidentali (Il Nepal dopo il terremoto), l’eclettica Milandri non si ferma mai. Tra un viaggio in capo al mondo e i tanti impegni in Italia con l’associazione Omnibus Omnes, da lei fondata a tutela delle popolazioni più deboli, l’autrice ha raccolto l’ultimo itinerario, svolto in condizioni estreme, nel suo quarto libro, In Alaska. Il paese degli uomini liberi (Ponte Sisto editore, pp. 152, € 14,00). L’abbiamo intervistata per farci raccontare in prima persona la sua capacità di entrare in punta di piedi nelle culture differenti, di approcciarle e di saper ascoltare le voci meno fortunate, ma anche per scoprire stati d’animo non scontati, obiettivi e qualche segreto legato a partenze e ritorni di una donna instancabile.
«Gli ultimi due anni? Un tempo infinito! Ecco le cose più rilevanti: con l’associazione che ho fondato, Omnibus Omnes, mi sono dedicata, dopo il Nepal, al sisma del Centro Italia che ha rivelato scenari altrettanto devastanti soprattutto da un punto di vista sociale, psicologico e burocratico. La società “moderna” presenta in realtà una miriade di talloni di Achille e svela una fragilità organizzativa che è una tragedia nella tragedia. Ho imparato molto da questa campagna di aiuti post-terremoto e forse anche troppo su una natura umana che è sempre meno umana. Con la Omnibus abbiamo poi erogato 61 borse di studio, un buon risultato, anche se rappresentano solo un piccolo sollievo. Sono inoltre stata da pochissimo adottata nella tribù di boscimani naro, in una famiglia di D’kar in Botswana [nell’Africa del Sud, ndr]. Un’adozione di un significato importantissimo, che si va ad aggiungere a quella in una famiglia crow, in Montana. È poi uscito il mio quarto libro e altri due sono in programmazione: uno proprio sui boscimani del Kalahari e un altro che è un manifesto anticonsumista, ispirato alla filosofia dei popoli indigeni».
 “In Alaska. Il paese degli uomini liberi”: ci racconta qualcosa sulla sua ultima fatica scritta?
“In Alaska. Il paese degli uomini liberi”: ci racconta qualcosa sulla sua ultima fatica scritta?
«Questo sull’Alaska e sugli inuit è in realtà un libro su noi occidentali riflessi in un contesto ambientale dove la Natura è signora e padrona. In Occidente vi sono debolezze, la lotta per la solitudine, uno stile di vita che, invece di darle, ci priva delle sicurezze e ci rende indifesi di fronte all’imprevisto atavico, al pericolo e alla solitudine: l’uomo del XXI secolo ha sopito tante delle caratteristiche meravigliose insite nell’essere umano e che lo hanno reso il padrone del pianeta. Egli spreca e consuma senza preoccuparsi del domani. È colui che ha fatto estinguere i bisonti dell’Ovest americano per sport e le balene in alcune zone dell’Artico per poter fare le stecche per i busti per signora».
Chi sono gli uomini liberi del libro e che cosa li contraddistingue?«Gli uomini liberi sono quelli che ho incontrato in Alaska: persone che hanno compiuto la dura scelta di rinunciare a un’esistenza agiata per vivere, come John, reduce del Vietnam, in una capanna di tronchi senza elettricità e senza riscaldamento, in un paese dove ci sono notti lunghe 24 ore e poi giorni di 24 ore e dove i grizzly sono un pericolo reale… La libertà si paga, ma permette di mettersi alla prova. Gli uomini liberi dell’Alaska sono quelli che hanno rinunciato agli agi della vita moderna, alla ricerca di se stessi e della propria umanità. Questo non vale però per Anchorage, l’unica città popolosa, dove negozi, uffici e traffico creano un’isola sicura per chi non ha bisogno di “evasione” verso differenti obiettivi personali».
 Com’è nata l’idea di esplorare l’Alaska? Quanti chilometri ha macinato in questo viaggio?
Com’è nata l’idea di esplorare l’Alaska? Quanti chilometri ha macinato in questo viaggio?
«L’idea è nata con il senso poetico di “ultima frontiera”, una sfida da affrontare. In realtà il libro racconta due miei viaggi in Alaska, per un totale di circa due mesi: uno realizzato d’estate e uno d’inverno a temperature estreme. Nel primo, con condizioni meteorologiche favorevoli, ho guidato in solitudine per oltre diecimila km, attraversando il circolo polare artico e arrivando a Dawson City, nello Yukon, cittadina nel nord del Canada leggendaria per la “corsa all’oro” [la scoperta del prezioso metallo in questi territori, verso la fine del XIX secolo, ha dato origine a una folta ondata migratoria di lavoratori, ndr]. Ho rischiato la vita sul serio e ciò mi è stato molto utile per rivedere la lista delle priorità della mia vita. Mi ha poi sorpresa soprattutto come l’uomo, in situazioni di reale solitudine e di sopravvivenza, sia maggiormente portato ad aiutare il prossimo e a comprenderlo senza giudicarlo».
In che modo si prepara, fisicamente e psicologicamente, ad affrontare itinerari anche pericolosi?«La valigia deve essere il più spartana possibile, da un punto di vista sia di comodità materiali sia di “ingombri” mentali. Per aprire gli occhi e la mente bisogna saper simulare la perdita di tutto ciò che diamo per scontato. La preparazione fisica è innanzitutto fatta di check-up medici; quella psicologica è una sorta di “spoliazione”».
Quali peculiarità ha riscontrato nella gente dell’Alaska?«Gli inuit sono un popolo meraviglioso, dalle conoscenze del mondo artico preziosissime. Lottano per sopravvivere, per mantenere la propria identità e la propria cultura. Ogni giorno l’uomo bianco li sottopone a grandi prove di resistenza psicologica. Lassù a Barrow, il “tetto del mondo”, per esempio, la vita è durissima».
 Quale popolo l’ha emozionata di più e perché? E dove ha trovato maggiore serenità?
Quale popolo l’ha emozionata di più e perché? E dove ha trovato maggiore serenità?
«Tutti hanno in comune una grande dignità, un pacifismo estremo – tranne in Papua Nuova Guinea [vedi articolo su LucidaMente Caccia alle “streghe” in Papua Nuova Guinea, ndr] –, una sorta di refrattarietà innata al senso del business e un enorme rispetto della natura. Poi, ovviamente, ci sono da fare molte distinzioni anche sulla base del quando e del come siano arrivate la colonizzazione e la violenza dell’uomo bianco. Serenità? Nel senso di rassegnazione, l’ho incontrata spesso; in realtà regna sovrana la paura di scomparire, di soccombere a uno stile di vita alieno che si insinua attraverso i cellulari, l’alcol, la depressione, il denaro… Il maggior senso di disperazione l’ho invece provato di fronte ai pigmei in Camerun: non sono censiti, non sono cittadini e saranno tra i primi popoli, che ancora esistono, a scomparire».
Nonostante le numerose avventure, immagino che non ci si abitui mai e ogni volta il viaggio rappresenti un’emozione unica, diversa…«Questo non è esattamente vero. In qualsiasi viaggio, nel mio cuore e nella mia mente sono con me tutte le esperienze dei precedenti e per stupirmi devo esplorare nuovi aspetti ed entrare molto in profondità. La scoperta che si rinnova ciclicamente è proprio la piccola differenza tra i popoli indigeni, tra le loro storie di discriminazioni subite. È una ragnatela grande come il mondo, una rete di fili invisibili che rende fra di loro i nativi come fratelli. E che li unisce come guardiani della Natura. Mi viene da dire che gli estranei siamo noi».
Del contatto con le persone del luogo, che cosa si porta dentro al ritorno? Si trova cambiata rispetto a quando era partita?«Quando visito un popolo, una famiglia, un capovillaggio, sono io a dire: “Ditemi come posso aiutarvi”. Ed è forse questo il mio atto più coraggioso, non quello di sfidare la savana e i leoni o le foreste e i grizzly: essere pronta ad accollarmi una missione che ha enormi potenzialità di fallimento, perché mi faccio raccontare i loro problemi e so che successivamente il più delle volte pochi ascolteranno. Perciò, quando torno sono sempre diversa da quando sono partita, con responsabilità e preoccupazioni per ogni volto che ho incontrato e che per me è una persona da rispettare e da proteggere».
L e è mai capitato di fare dei confronti tra la vita vissuta lontano da casa e quella, rassicurante, di tutti i giorni?
e è mai capitato di fare dei confronti tra la vita vissuta lontano da casa e quella, rassicurante, di tutti i giorni?
«Il confronto con la mia vita qui in Italia è sempre immediato e catastrofico, direi. Quando torno, faccio attenzione a tante piccole cose stupide che non hanno reale importanza e mi infastidisco. Probabilmente viaggiare in solitaria mi porta ad amare l’isolamento e una vita spartana, anche qua. Ovviamente non ci sono solo due mondi, quello dei popoli indigeni e quello moderno occidentale. Qua da noi c’è la vita dei paesi, in montagna per esempio, dove si respira un’aria diversa rispetto alle grandi città. C’è la vita delle piccole cittadine, dove ancora permane la cultura della tradizione, qui in Italia come in Inghilterra, in Spagna e in molti altri stati. La globalizzazione sta cancellando l’identità di tutti i popoli, non solo di quelli indigeni».
Che sensazione prova nell’affrontare la scrittura di un libro dopo essere tornata?«Scrivere del viaggio è come riviverlo e riassaporarne ogni istante, attraverso i filmati, le foto, i miei appunti… Scrivere è un modo per consegnare ciò che ho appreso a tutti i lettori. Il mio scopo fondamentale è emozionare, divulgare, far riflettere».
Quale viaggio rifarebbe anche subito e perché?«Per rivedere i popoli che ho conosciuto, li rifarei tutti. Per incontrare le persone che ho già incontrato e a cui penso spesso, lo farei subito, ovunque. Ma non rifarei ad ogni modo lo “stesso” viaggio. Non con lo stesso spirito. Non con gli stessi occhi. Poiché non sarebbe mai uguale. Ho ansia di conoscenza e l’itinerario che ho nel cassetto è in Siberia, per visitare gli ultimi popoli indigeni. Ci ho già provato, però è molto difficile da organizzare e richiede risorse economiche ingenti, oltre a precauzioni estreme per potersi muovere. In alcune zone si potrebbe arrivare solo in elicottero. Come in Alaska, in inverno il suolo è ghiacciato e si può percorrere, ma le temperature sono esageratamente basse; in estate, d’altra parte, molte zone diventano simili a paludi e sono impercorribili».
Le difficoltà elencate sono oggettive e comprensibili, ma sappiamo che Raffaella Milandri non si arrenderà e le auguriamo di cuore di poter realizzare, in completa sicurezza, il sogno di recarsi anche in Siberia.
Le immagini: alcune foto della scrittrice e viaggiatrice solitaria Raffaella Milandri e la copertina del suo quarto libro, In Alaska. Il paese degli uomini liberi.
Maria Daniela Zavaroni
(LucidaMente, anno XII, n. 144, dicembre 2017)














