Nel nostro Paese, si sa, il calcio è una vera e propria religione che ogni anno mobilita milioni di “fedeli”: una miriade di appassionati da ormai un secolo protagonista del mondo del pallone. Ma quando e come gli italiani si sono interessati a questo sport giunto dalla Gran Bretagna?
Marzo 2020: inizia la pandemia e gli stadi si svuotano. La Covid-19 ha colpito anche il mondo del calcio e una delle conseguenze più visibili è l’assenza del pubblico negli impianti sportivi. Da ormai più di un anno il silenzio assordante degli spalti è il triste contorno di ogni fine settimana calcistico. Una situazione di questo tipo è inedita per il mondo del pallone. Allora noi in questo articolo vogliamo provare a scoprire quali sono state le origini di una tale passione e attaccamento alla propria squadra del cuore da parte di tantissime persone che da decenni colorano le tribune di tutta Italia.
Dopo il terribile periodo di crisi dovuto alla Grande Guerra, l’Italia aveva pian piano registrato qualche progresso in termini di reddito pro capite, con una media che nel 1929 salì a 3.079 lire rispetto alle 2.387 del 1919. Nel frattempo, anche i tempi di lavoro avevano conosciuto discreti sviluppi legislativi: nel 1907 era stato riconosciuto per legge il diritto a un giorno di riposo settimanale; nel 1923 l’orario lavorativo era stato portato a otto ore giornaliere, o comunque a un massimo di quarantotto settimanali; più tardi, nel 1926, le celebrazioni civili erano state equiparate a quelle cattoliche e dunque tali giorni erano divenuti festivi; infine erano stati concessi almeno dieci giorni all’anno di riposo per gli impiegati privati e sei giorni per gli operai. Questi dati, tradotti in pratica, significarono un lieve miglioramento del tenore di vita e una maggiore disponibilità di tempo libero e, dunque, anche una crescita della pratica sportiva. L’avvicendamento tra collettività e sport fu favorito anche da altri fattori: l’arrivo in Italia di quelle mode circa il tempo libero che stavano dilagando in tutta Europa; l’affermazione dell’attività fisica professionistica, capace di alzare il livello tecnico degli atleti; la comparsa di personaggi dalle grandi disponibilità economiche, in grado di investire grosse somme di denaro nello sport e nel calcio in particolare; ginnici di spicco che più frequentemente rispetto al passato provenivano anche dai ceti popolari.
 Considerando tutto ciò, si capisce bene allora che masse sempre più grandi furono attratte dallo sport: sia come atleti sia come appassionati. In questo contesto, lo spettacolo calcistico andò costituendo una forma di aggregazione e socialità, recando con sé, negli anni Venti, l’esplosione del fenomeno del tifo dopo che fin dal sorgere dello sport agonistico aveva iniziato a svilupparsi e, conoscendo un’accelerata nel dopoguerra, aveva finito per passare da un termine del gergo calcistico a fatto culturale. In questi anni si registrò un discreto interesse di massa per le compagini calcistiche che, proliferando in tutta la penisola, stavano conoscendo la consacrazione popolare. La cartina di tornasole di questo nuovo costume furono gli stadi, i quali sempre più spesso erano invasi da “masse entusiaste”. A tal proposito possiamo ricordare alcune partite, come la finale di campionato del 22 luglio 1923 tra Genoa e Lazio che, sugli spalti del Campo della Rondinella di Roma, registrò la presenza di circa 10.000 spettatori per un incasso di 88.000 lire; la partita amichevole disputata allo stadio Velodromo Sempione di Milano tra la nazionale dell’Italia e quella dell’Austria il 15 gennaio 1922, con 20.000 spettatori che assistettero al 3 a 3 finale, per un incasso di 207.000 lire. Tuttavia, il match che nello stesso periodo registrò l’affluenza maggiore fu quello inaugurale dello stadio Littoriale (odierno Dall’Ara) di Bologna il 29 maggio 1927, evento nel quale si sfidarono le nazionali di Italia e Spagna con gli azzurri che si imposero per 2-0: in quest’occasione si recarono all’impianto felsineo oltre 50.000 spettatori, tra cui l’infante di Spagna don Alfonso. Da sottolineare il fatto che, per la prima volta, una partita di calcio coinvolse ristoratori, albergatori, tassisti: dunque si mobilitarono non solo gli ambienti sportivi, bensì tutta la città.
Considerando tutto ciò, si capisce bene allora che masse sempre più grandi furono attratte dallo sport: sia come atleti sia come appassionati. In questo contesto, lo spettacolo calcistico andò costituendo una forma di aggregazione e socialità, recando con sé, negli anni Venti, l’esplosione del fenomeno del tifo dopo che fin dal sorgere dello sport agonistico aveva iniziato a svilupparsi e, conoscendo un’accelerata nel dopoguerra, aveva finito per passare da un termine del gergo calcistico a fatto culturale. In questi anni si registrò un discreto interesse di massa per le compagini calcistiche che, proliferando in tutta la penisola, stavano conoscendo la consacrazione popolare. La cartina di tornasole di questo nuovo costume furono gli stadi, i quali sempre più spesso erano invasi da “masse entusiaste”. A tal proposito possiamo ricordare alcune partite, come la finale di campionato del 22 luglio 1923 tra Genoa e Lazio che, sugli spalti del Campo della Rondinella di Roma, registrò la presenza di circa 10.000 spettatori per un incasso di 88.000 lire; la partita amichevole disputata allo stadio Velodromo Sempione di Milano tra la nazionale dell’Italia e quella dell’Austria il 15 gennaio 1922, con 20.000 spettatori che assistettero al 3 a 3 finale, per un incasso di 207.000 lire. Tuttavia, il match che nello stesso periodo registrò l’affluenza maggiore fu quello inaugurale dello stadio Littoriale (odierno Dall’Ara) di Bologna il 29 maggio 1927, evento nel quale si sfidarono le nazionali di Italia e Spagna con gli azzurri che si imposero per 2-0: in quest’occasione si recarono all’impianto felsineo oltre 50.000 spettatori, tra cui l’infante di Spagna don Alfonso. Da sottolineare il fatto che, per la prima volta, una partita di calcio coinvolse ristoratori, albergatori, tassisti: dunque si mobilitarono non solo gli ambienti sportivi, bensì tutta la città.
 Contemporaneamente, un altro interessante fenomeno prendeva corpo in seno al tifo: il campanilismo sportivo, che spesso rifletteva le rivalità locali tradizionali coinvolgendo piccoli e grandi centri. Esso prese una particolare piega a partire dagli anni Venti in quelle città nelle quali le numerose squadre sorte agli albori del calcio si unificarono in una sola società cittadina. Tale processo portò alla fusione anche delle varie tifoserie esistenti, con la conseguenza di una completa identificazione tra squadra e capoluogo e la creazione tra queste di un rapporto quasi viscerale, come nel caso di Bologna, Bari, Cagliari, Firenze e Napoli. Tuttavia, in altri grandi centri italiani persistette la presenza di due grandi club, come a Genova, Milano, Roma e Torino. Qui anche le tifoserie rimasero divise in due grandi fazioni aumentando la rivalità reciproca, che trovava la sua massima espressione nei derby. In linea di massima, comunque, la caratteristica del tifo calcistico di quegli anni fu la tendenza a supportare il club di riferimento della propria città: si dovette attendere il quinquennio 1930-1935 con la Juventus campione d’Italia per cinque volte consecutive sotto la guida di Carlo Carcano per assistere alla nascita di tifoserie nazionali. In ogni caso la passione intorno al calcio era in rapida ascesa, tanto che cominciò a svilupparsi l’usanza di seguire e sostenere la propria squadra nelle trasferte: cosa che spesso era incentivata dalle stesse società.
Contemporaneamente, un altro interessante fenomeno prendeva corpo in seno al tifo: il campanilismo sportivo, che spesso rifletteva le rivalità locali tradizionali coinvolgendo piccoli e grandi centri. Esso prese una particolare piega a partire dagli anni Venti in quelle città nelle quali le numerose squadre sorte agli albori del calcio si unificarono in una sola società cittadina. Tale processo portò alla fusione anche delle varie tifoserie esistenti, con la conseguenza di una completa identificazione tra squadra e capoluogo e la creazione tra queste di un rapporto quasi viscerale, come nel caso di Bologna, Bari, Cagliari, Firenze e Napoli. Tuttavia, in altri grandi centri italiani persistette la presenza di due grandi club, come a Genova, Milano, Roma e Torino. Qui anche le tifoserie rimasero divise in due grandi fazioni aumentando la rivalità reciproca, che trovava la sua massima espressione nei derby. In linea di massima, comunque, la caratteristica del tifo calcistico di quegli anni fu la tendenza a supportare il club di riferimento della propria città: si dovette attendere il quinquennio 1930-1935 con la Juventus campione d’Italia per cinque volte consecutive sotto la guida di Carlo Carcano per assistere alla nascita di tifoserie nazionali. In ogni caso la passione intorno al calcio era in rapida ascesa, tanto che cominciò a svilupparsi l’usanza di seguire e sostenere la propria squadra nelle trasferte: cosa che spesso era incentivata dalle stesse società.
Va detto però che talvolta fenomeni come il campanilismo e il supporto alla squadra del cuore venivano esasperati e diventava frequente che si verificassero episodi di violenza e scontri tra tifoserie. Una vicenda particolarmente significativa è quella che vide protagonisti i sostenitori del Bologna e del Genoa: ci riferiamo allo “Scudetto delle pistole”, di cui abbiamo parlato in questo stesso numero di LucidaMente. Con tale espressione si indica il titolo di “campione d’Italia” conquistato dalla compagine felsinea nella stagione 1924-1925, al termine di cinque durissime sfide contro i rossoblù di Genova. A caratterizzare gli incontri furono la violenza e gli scontri scoppiati tra i sostenitori delle due squadre, che conobbero il proprio apice il 5 luglio alla stazione Porta Nuova di Torino quando, dopo la partita, le due frange di tifosi entrarono a stretto contatto dando luogo a una sparatoria, che causò qualche ferito. Va precisato che il tifo all’epoca non aveva un’organizzazione così come la ebbe in seguito e, dunque, anche la violenza era spontanea, senza premeditazione.
 Ma in che modo un termine che fino a quel momento aveva designato una malattia che falcidiava la popolazione cominciò a indicare un fenomeno sportivo e sociale? L’origine di “tifo” in ambito agonistico va ricercata sugli spalti già prima della Grande Guerra, quando iniziò a delinearsi una differenza tra il termine medico “tifico” e lo sportivo “tifoso”. Il tifo all’epoca era una delle malattie che gli italiani conoscevano meglio. Come suggerito da Giovanni Dovara nel 1923 sulla rivista Il calcio di Genova, la traslazione di significato dall’ambito clinico a quello sportivo fu favorita dal parallelismo tra il carattere ciclico del tifo calcistico, che si rinnovava di settimana in settimana, e quello delle febbri tifoidi, che si ripetevano stagionalmente ogni anno. Intanto, anche sulla carta stampata il termine stava divenendo di uso comune; così una cronaca della partita tra Naples e Savoia del dicembre 1920 riportata da Antonio Papa e Guido Panico nel loro libro Storia sociale del calcio in Italia. Dai club dei pionieri alla nazione sportiva (1887-1945): «Per la calma e il buon volere di pochi, non si sono lamentati incidenti di una certa importanza, ma i continui battibecchi del pubblico hanno valso a mettere in luce il soverchio campanilismo di qualche supporter torrese e l’esagerato “tifo” di qualche socio bleu-celeste».
Ma in che modo un termine che fino a quel momento aveva designato una malattia che falcidiava la popolazione cominciò a indicare un fenomeno sportivo e sociale? L’origine di “tifo” in ambito agonistico va ricercata sugli spalti già prima della Grande Guerra, quando iniziò a delinearsi una differenza tra il termine medico “tifico” e lo sportivo “tifoso”. Il tifo all’epoca era una delle malattie che gli italiani conoscevano meglio. Come suggerito da Giovanni Dovara nel 1923 sulla rivista Il calcio di Genova, la traslazione di significato dall’ambito clinico a quello sportivo fu favorita dal parallelismo tra il carattere ciclico del tifo calcistico, che si rinnovava di settimana in settimana, e quello delle febbri tifoidi, che si ripetevano stagionalmente ogni anno. Intanto, anche sulla carta stampata il termine stava divenendo di uso comune; così una cronaca della partita tra Naples e Savoia del dicembre 1920 riportata da Antonio Papa e Guido Panico nel loro libro Storia sociale del calcio in Italia. Dai club dei pionieri alla nazione sportiva (1887-1945): «Per la calma e il buon volere di pochi, non si sono lamentati incidenti di una certa importanza, ma i continui battibecchi del pubblico hanno valso a mettere in luce il soverchio campanilismo di qualche supporter torrese e l’esagerato “tifo” di qualche socio bleu-celeste».
Tuttavia, solo molti anni più tardi la parola “tifo”, con valenza agonistica, conobbe la consacrazione ufficiale: precisamente nel 1935 nel Dizionario moderno di Alfredo Panzini, mentre più tardi, nel 1939, comparve con quest’accezione anche nell’Enciclopedia Italiana. Parallelamente comparvero pure degli scritti circa tale fenomeno. Nel 1934 Massimo Bontempelli in Tifo e tifi diversi ne fece un’analisi antropologica, differenziando i “tifi” in base alle zone geografiche italiane; dimostrando di cogliere l’importanza delle folle che si accalcavano sugli spalti quale attore fondamentale nello spettacolo sportivo. Altri letterati, come Francesco Flora, si concentrarono sugli aspetti culturali, paragonando lo spettacolo sportivo a una tragedia teatrale. Comunque, come ogni novità che si presenta, l’accoglienza del tifo fu ambivalente: in linea di massima fu favorevole, anche se vi furono appunto coloro che manifestarono preoccupazione per l’eventuale deriva sociale di chi ne fosse stato coinvolto emotivamente.
Oggi si reputa il tifo un fenomeno che attraversa tutte le classi sociali senza distinzione alcuna; tuttavia, tradizione vuole che le varie tifoserie abbiano avuto ciascuna una propria origine e traiettoria particolare. È così che, ad esempio, a Milano alla tifoseria del Milan venivano associati proletari, operai, lavoratori manuali, tant’è vero che vennero soprannominati cascavìt, mentre a quella dell’Inter il mondo borghese. A Torino la Juventus inizialmente era in auge tra imprenditori, intellettuali e studenti; ma, con l’acquisizione della proprietà da parte di Edoardo Agnelli, che causò un avvicinamento tra il “mondo Fiat” e il mondo juventino, anche gli operai iniziarono a simpatizzare per la compagine bianconera. In seguito, il quinquennio d’oro avvicinò alla Juventus appassionati da varie parti d’Italia, facendo diventare quello juventino un tifo nazionale, abbandonando la connotazione campanilistica. Negli anni a seguire anche Inter e Milan divennero due club che poterono vantare numerosissimi sostenitori in tutto il Paese. Il tifo conobbe la propria consacrazione anche nei luoghi della socialità e il simbolo ne divenne il bar. Era qui che gli appassionati potevano leggere le notizie sportive sui giornali e discuterne tra loro: nacque così l’embrione della figura romantica del tifoso trepidante che aspetta tutta la settimana la partita della domenica per seguire le vicende della propria squadra del cuore, che esplose definitivamente nel secondo dopoguerra. Oggetto invece della socialità divenne la radio: quando la squadra era in trasferta e i tifosi non potevano seguirla essa era l’unico mezzo per conoscerne i risultati. Tuttavia, le comunicazioni erano ancora precarie e lente e molto spesso le sedi dei quotidiani, che avevano le notizie quasi in tempo reale, divenivano luogo di assembramenti di persone in attesa delle notizie dai campi.
Le immagini: la Nazionale italiana di calcio il giorno della partita contro la Spagna nel 1927; tifosi assiepati attorno a un campo di calcio; spalti di uno stadio gremiti di tifosi.
Mario Curreli
(LucidaMente 3000, anno XVI, n. 186, giugno 2021)














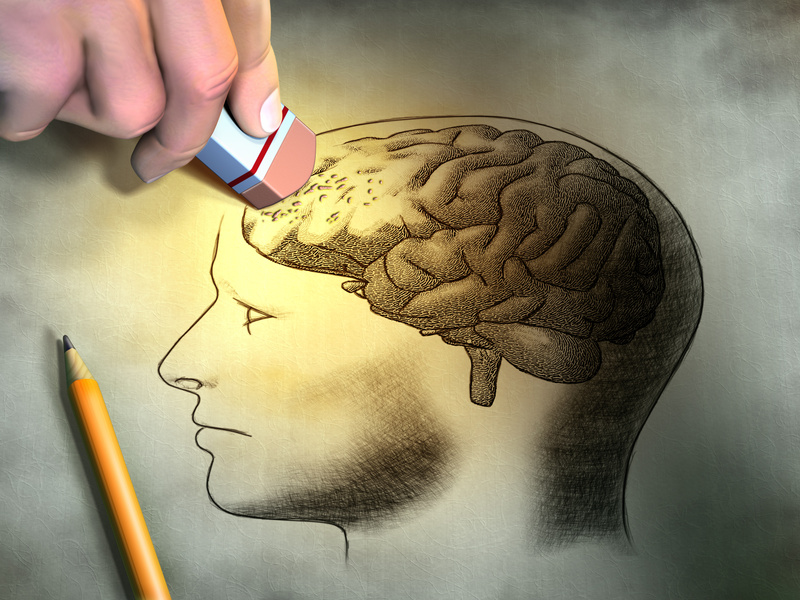



Che Bella rivisitazione di come era allora il Calcio….