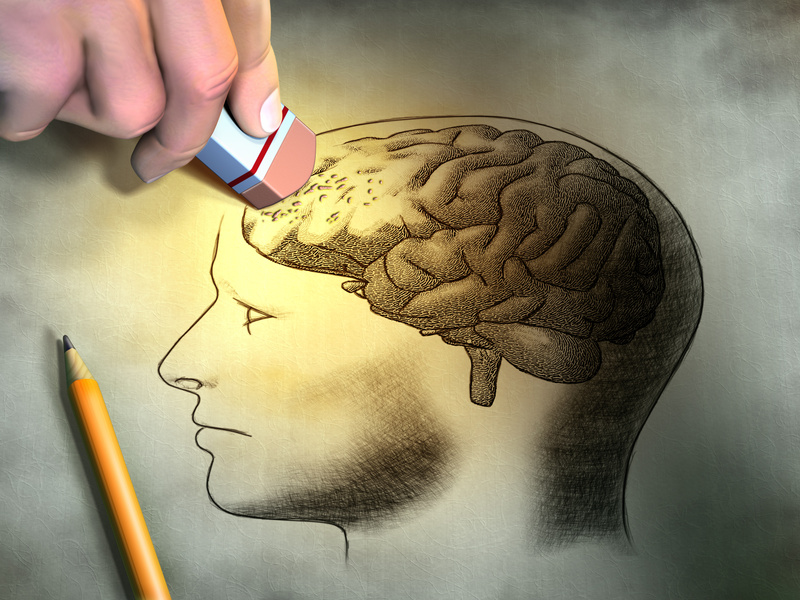Dopo aver visto il significato del banchetto nel tedesco Günter Grass, nella seconda parte di questo breve saggio vediamo la delicatezza insita nella cultura della narratrice giapponese
Il cibo, se naturale, concupisce i sensi, sublima l’incontro armonioso con la terra e il regno vegetale, veicolando preziose suggestioni sul potenziale della vita umana. Il cibo non è solo un importante acceleratore nel processo di costruzione identitaria del secondo Novecento. Nelle opere della scrittrice giapponese Ito Ogawa (Il ristorante dell’amore ritrovato, Neri Pozza, pp. 192, € 9,00), esso diviene sintesi perfetta dell’Io, dismettendo la morfologia del bene comune e universale per assumere tratti specifici unici e irripetibili.
 Prima di ardere la legna e preparare la mensa al forestiero, le donne della narratrice nipponica riflettono sulla natura esclusiva e indivisibile delle persone che accolgono nelle loro locande. Della convivialità celebrata dai romanzi di Günter Grass (leggi la prima parte di questo saggio) difficilmente si troverà traccia nella scrittura della Ogawa. Ciascuno è alla ricerca di sé nel trambusto della modernità giapponese: esseri sparuti in fuga dalla tentacolarità della capitale, coppie alla ricerca dell’antico afflato d’amore, uomini o donne alla ricerca di risposte che tardano ad arrivare nelle loro vite. L’esperimento di una giovanetta smarritasi nel mondo a causa della propria indolenza si volge, non senza ingenuità critica da parte dell’autrice e ilarità bonaria nella controfigura romanzesca, in un processo di indagine sull’uomo contemporaneo e sulla sua incapacità ad ascoltarsi. Le pietanze, con i loro profumi e la sinestesia di immagini prodotte con l’alternarsi di piatti delicati e pregni di cromatismi bizzarri, risvegliano le coscienze intorbidite da una società allineata al mantra del progresso a tutti i costi.
Prima di ardere la legna e preparare la mensa al forestiero, le donne della narratrice nipponica riflettono sulla natura esclusiva e indivisibile delle persone che accolgono nelle loro locande. Della convivialità celebrata dai romanzi di Günter Grass (leggi la prima parte di questo saggio) difficilmente si troverà traccia nella scrittura della Ogawa. Ciascuno è alla ricerca di sé nel trambusto della modernità giapponese: esseri sparuti in fuga dalla tentacolarità della capitale, coppie alla ricerca dell’antico afflato d’amore, uomini o donne alla ricerca di risposte che tardano ad arrivare nelle loro vite. L’esperimento di una giovanetta smarritasi nel mondo a causa della propria indolenza si volge, non senza ingenuità critica da parte dell’autrice e ilarità bonaria nella controfigura romanzesca, in un processo di indagine sull’uomo contemporaneo e sulla sua incapacità ad ascoltarsi. Le pietanze, con i loro profumi e la sinestesia di immagini prodotte con l’alternarsi di piatti delicati e pregni di cromatismi bizzarri, risvegliano le coscienze intorbidite da una società allineata al mantra del progresso a tutti i costi.
Nella locanda “Al Lumachino” giungono personaggi ignari delle proprie potenzialità, uomini il cui senso della vita è scandito unicamente dai ritmi del lavoro e della carriera, donne che hanno perduto fiducia nell’amore, individui non accettati a causa della loro diversità e un campione variegato di tipi sociali alle prese con smarrimento e metamorfosi di un Io in divenire. La scrittura della Ogawa trattiene il lettore grazie alla semplicità: mentre Grass si diverte a fare a pezzi gli assiomi del romanzo contemporaneo caricando la penna di suggestioni al limite del fantastico, l’artista nipponica costruisce trame dettate dal fluire perenne della vita.
 La quotidianità alberga nelle sue pagine, trasferendo al lettore l’irenismo dell’animo giapponese che si contenta di ritrovare se stesso dopo un breve soggiorno nella locanda. Il soggiorno stesso al “Lumachino”, pur nella sua staticità, diviene la metafora di un lungo viaggio entro se stessi. In tale processo di “découverte”, il cibo assume valenze affini alla madeleine proustiana, veicolando il ritorno in superficie dei ricordi, come pure delle esperienze sotterrate dalla disillusione. Tutto ciò rinsalda in Ringo, protagonista indiscussa del romanzo, il pensiero di aver compiuto la scelta giusta: dedicarsi a coloro che, al pari di sé, hanno smarrito la traiettoria del buon vivere giapponese. Che cosa redime e rinfranca l’animo umano? Anche la risposta nipponica giunge dal cibo, ma nell’arcipelago il piatto non viene colmato alla rinfusa. La geometria dei sapori e la magia degli odori si ricompone dopo aver scrutato per giorni l’avventore e averne individuato peculiarità e tratti umani. La scelta delle pietanze non è mai lasciata al caso, come non è fortuito il finale: «Non smetterò mai di cucinare pietanze che possano regalare anche solo un pizzico di felicità alle persone. E voglio farlo qui, per sempre, nella cucina del mio ristorante».
La quotidianità alberga nelle sue pagine, trasferendo al lettore l’irenismo dell’animo giapponese che si contenta di ritrovare se stesso dopo un breve soggiorno nella locanda. Il soggiorno stesso al “Lumachino”, pur nella sua staticità, diviene la metafora di un lungo viaggio entro se stessi. In tale processo di “découverte”, il cibo assume valenze affini alla madeleine proustiana, veicolando il ritorno in superficie dei ricordi, come pure delle esperienze sotterrate dalla disillusione. Tutto ciò rinsalda in Ringo, protagonista indiscussa del romanzo, il pensiero di aver compiuto la scelta giusta: dedicarsi a coloro che, al pari di sé, hanno smarrito la traiettoria del buon vivere giapponese. Che cosa redime e rinfranca l’animo umano? Anche la risposta nipponica giunge dal cibo, ma nell’arcipelago il piatto non viene colmato alla rinfusa. La geometria dei sapori e la magia degli odori si ricompone dopo aver scrutato per giorni l’avventore e averne individuato peculiarità e tratti umani. La scelta delle pietanze non è mai lasciata al caso, come non è fortuito il finale: «Non smetterò mai di cucinare pietanze che possano regalare anche solo un pizzico di felicità alle persone. E voglio farlo qui, per sempre, nella cucina del mio ristorante».
Le immagini: a uso gratuito da pixabay.com.
Gianluca Sorrentino
(LucidaMente 3000, anno XVI, n. 187, luglio 2021)